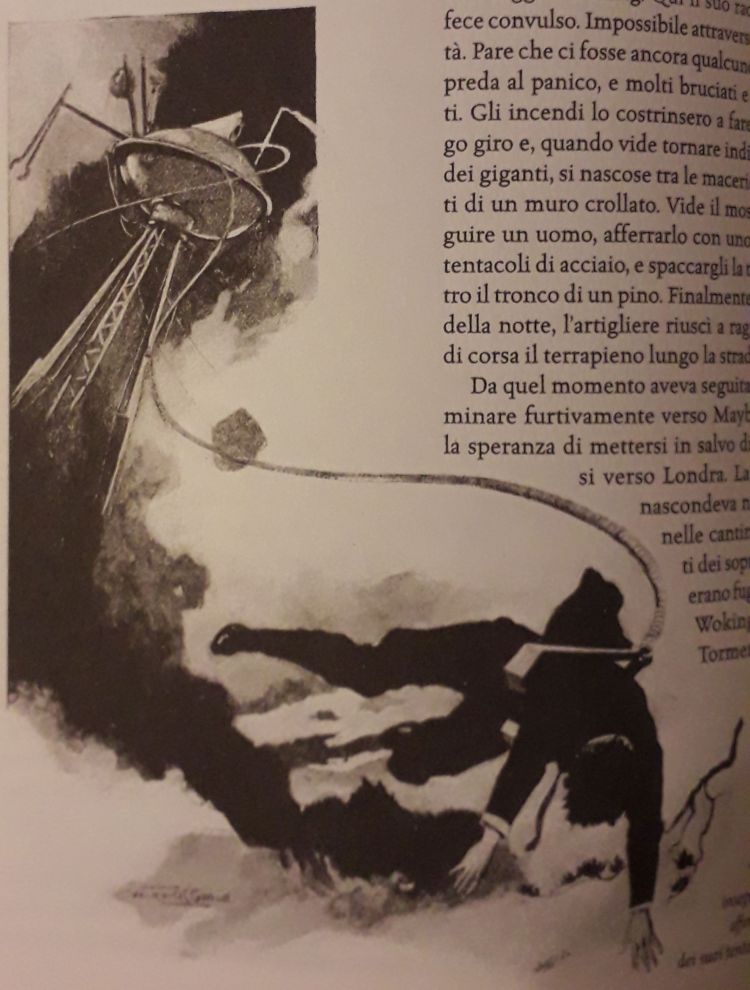[Di seguito è riportata la seconda parte del testo che abbiamo scritto per l’episodio del podcast dedicato al celebre romanzo di H. G. Wells. La prima parte è in questo articolo.
Il socio ed io ci saremmo dovuti scambiare una serie di battute, alternandoci nel discorso, ed il testo è organizzato in tal modo. Purtroppo il socio non è riuscito ad essere presente alla registrazione, pertanto l’audio, che può essere ascoltato e scaricato qui, presenta una struttura un po’ diversa.]
Il romanzo alla radio
V: Veniamo al Welles che tu dicevi prima, che è Orson e non H. G. Più celebre del romanzo è lo spettacolo radiofonico che andò in onda la sera del 30 ottobre del 1938 su un’emittente del circuito CBS. La musica viene interrotta per annunciare che l’osservatorio di Chicago ha visto grandi fiammate sulla superficie di Marte, poi la normale programmazione continua. Salvo poi essere a più riprese interrotta con notizie dai toni sempre più concitati: lo speaker ci racconta di un oggetto caduto dal cielo nei pressi di Grovers Mills, nello stato del New Jersey.
G: Bene, piano piano gli alieni si stanno avvicinando a New York.
V: quello accadrà poi nel cinema, sarà un po’ una fissa degli americani. Gli annunci alla radio raccontano poi di alieni che escono dall’oggetto misterioso ed iniziano a fare fuoco contro i presenti, con tanto di grida ed effetti sonori registrati dal presunto inviato sul posto. Si segue il copione del romanzo, è il mezzo e il modo di narrarlo a cambiare. Questo programma sperimentale, scritto e recitato da un ventitreenne Orson Welles, fa nascere un mito, quello che poi vediamo ben raccontato in Quarto potere. Fin dal giorno successivo al programma radiofonico i giornali iniziano a parlare di un panico che avrebbe travolto gli americani, con scene apocalittiche a New York e tale notizia viene talmente ripetuta e amplificata che a tutt’oggi si crede veramente che gli americani quella notte del ‘38 fossero impazziti in massa.
G: Quanto c’è di vero in questa leggenda urbana?
V: È necessario fare una parentesi storica. Anzitutto non c’era una radio in ogni famiglia, erano ancora costose e non tanto diffuse. C’era tuttavia uno scontro aperto tra il nuovo mezzo di comunicazione e il vecchio, la stampa cartacea. Durante gli anni della Grande Depressione la radio aveva infatti iniziato ad accaparrarsi spazi pubblicitari a discapito dei giornali. L’episodio della trasmissione di Welles offrì un’ottima occasione sia per attaccare che per far progredire la radio. I giornali colsero l’occasione per screditarla come mezzo di comunicazione che ancora doveva provare la sua affidabilità e che anzi si era dimostrato potenzialmente pericoloso.
G: quindi non ci fu nessuna scena di panico?
V: Non ci fu nessun panico di massa: un sondaggio su 5000 persone che veniva abitualmente fatto per capire che programmi seguissero gli ascoltatori ci mostra che il programma di Welles, quella sera, fu seguito forse da un 2% scarso di pubblico perché c’era, a fargli concorrenza, un ben più noto spettacolo comico. Non c’è alcuna prova che poi gli americani abbiano in massa cambiato stazione durante l’intervento di Welles. Un libro pubblicato nel 1940, “The invasion from Mars” di Hadley Cantril, ha poi contribuito a cristallizzare il mito creato dai giornali.

La guerra dei mondi al cinema
V: Il romanzo non ha avuto molti adattamenti diretti.
G: solo due in effetti, uno del ‘53 ed uno del 2005. In entrambi il terreno di battaglia è l’America piuttosto. Il primo di essi è innovativo per il cinema come il libro lo fu per la letteratura. A cominciare dal rifiuto di utilizzare i vecchi razzi alla Flash Gordon come mezzo per l’invasione. L’idea di dare l’apparenza di mante alle astronavi marziane e quella di teste di cobra per le torrette armate diede un nuovo look alla fantascienza.
V: La trama del film si discosta di molto da quella del romanzo, mantenendo più punti in comune con lo sceneggiato radiofonico: l’invasione è globale e l’intervento dell’esercito avviene subito. La resistenza umana viene spacciata facilmente attraverso le macchine mortali di cui gli alieni dispongono e persino le armi nucleari si rivelano inefficaci. Quando l’umanità è sull’orlo dell’estinzione interviene la natura a fermare i marziani, come accade nel romanzo.
G: Il film ha vinto l’oscar per i migliori effetti speciali e dal 2011 ha trovato posto nella biblioteca del Congresso degli Stati Uniti per la sua importanza storica e artistica.
V: Il film ha un remake nel 2005. Spielberg porta ad un livello più personale l’invasione aliena, concentrandosi sulle vicende di una famiglia del New Jersey rimanendo però quanto più possibile fedele alla trama del romanzo.
G: Gli effetti speciali sono adeguati ai tempi, la storia no:
V: il personaggio di Tom Cruise, un semplice operaio, è scritto forse troppo in fretta e rimane schiavo del suo destino e questo non è l’unico difetto della sceneggiatura. I famigerati tripodi alieni sono già sulla Terra, dormienti nel sottosuolo da tempo imprecisato.
G: E non se ne è mai accorto nessuno?
V: Eh, pare di no. Gli alieni, che vengono da chissà dove con chissà quali mezzi, si limitano a piombare dal cielo a bordo di strane capsule che portano i loro piloti direttamente a bordo dei tripodi, che irrompono dal terreno cominciando la loro opera distruttrice.
G: Sembra poi che gli umani vengano raccolti perché il loro sangue serve da concime alle piante che gli alieni stanno diffondendo probabilmente per terraformare il nostro pianeta alle loro esigenze.
V: Nel romanzo sono i marziani che si nutrono direttamente del nostro sangue, come vampiri, e su questo fatto Wells fa un’interessante digressione sulla loro fisiologia che ben testimonia la passione dello scrittore per le scienze naturali. Da citare infine i mockbusters dell’Asylum del 2005 e del 2008, “War of the Worlds – l’invasione” e “ War of the Worlds 2 – The next wave”. Per chi conosce questa casa produttrice non c’è bisogno di dire altro.

L’eredità cinematografica
V: Innumerevoli sono gli echi che questo romanzo ha avuto nel cinema e nella televisione dando vita al sempre verde filone dei film sulle invasioni aliene. Senza scavare troppo nel bianco e nero e limitandoci a tempi più recenti, ricordiamo la serie televisiva “Visitors” del 1984 e poi rifatta nel 2013, con i suoi celebri alieni rettili…
G: ah, i rettiliani, vuoi dire
V: non proprio quelli. Altro prodotto figlio de “La guerra dei mondi” è “Indipendence Day”. Qui il virus che sconfigge gli alieni è figlio della tecnologia
G: e gli alieni vengono presi a pugni in faccia.
V: ricordiamo ancora, solo per citarne alcuni, la serie tv “Falling Skies”, il film della Hasbro “Battleship”, poi “Battle: Los Angeles”, “Skyline” con il suo seguito. Anche John Carpenter ci parla di un’invasione aliena in “Essi vivono” film del 1988 a cui abbiamo dedicato un episodio delle pergamene. Non manca qualche variante comica sul tema, ad esempio “Mars attacks” di Tim Burton.
G: Il romanzo di Wells a più di un secolo dalla sua pubblicazione ha messo radici così profonde nell’immaginario collettivo da essere usato come trampolino da Hubbard per lanciare la sua religione, Scientology. Hubbard scrisse vari romanzi di fantascienza, tra cui “Battaglia per la terra”, da cui è stato tratto l’omonimo film in cui troviamo la civiltà umana sull’orlo dell’estinzione e schiava degli invasori alieni.
V: Il film è orribile. Non guardatelo. I titoli non si esauriscono qui e siamo piuttosto sicuri che Hollywood sfornerà ancora altri film a tema: in fin dei conti l’osservazione e l’esplorazione dello spazio non smetteranno mai di far viaggiare l’immaginazione dell’uomo.
G: Citiamo un ultimo titolo che ci permette di collegarci alla produzione giapponese: “Pacific Rim”.
V: In questo film vediamo che da una imprecisata dimensione o mondo gli alieni di turno aprono portali per scagliare immensi mostri, i Kaiju, contro l’umanità. Il film è un omaggio a tutte le serie di animazione giapponese che vedono una civiltà ostile, non sempre aliena, cercare di invadere il Giappone con i suoi mostri, meccanici o organici, e, dall’altra parte gli eroi a bordo dei loro robottoni che cercano di ostacolare gli invasori. Se in Goldrake, Daitarn, Daltanious, Zambot 3, e “La corazzata spaziale Yamato”, giusto per fare qualche nome, i cattivi sono extra-terresti, in Mazinga, Jeeg in alcune serie di Getter i nemici sono antiche civiltà terrestri dimenticate dal tempo e rimaste solo nei miti e nelle leggende.
Conclusione
V: Con questo concludiamo l’episodio. Un ringraziamento per l’ascolto da parte della penna…
G: … e del calamaio…
V: ed saluto a Perseverance che sta tutto solo nelle sperdute e desolate
G: speriamo
V: lande marziane.
Fonti: La fantascienza di H. G. Wells, Mondadori Oscar Draghi, 2018; Jefferson Pooley & Michael J. Socolow, The Myth of the War of the Worlds Panic, Slate, 28 ottobre 2013.